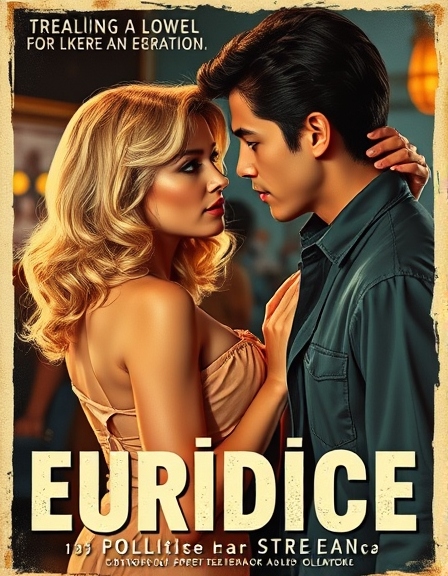GIORGIO VIALI
MEDIAGRAMMI
ELEMENTI
La recensione è uno di quei compiti che un po’ ti schiacciano, quasi quanto farlo deve aver meravigliosamente terrorizzato la regista. Perché un’idea così complessa e potente, così fragile e dolente come la sua protagonista, così lacerante e delicata, così piena di male fisico e d’animo ma anche di luce soffocata è di quelle che impegnano ogni cellula di te, ogni neurone. Come autrice e come spettatrice. Che ti entusiasmano e ti annichiliscono, che sanno farti sentire fuori posto, sporca, ma anche dentro un capolavoro, pieno di ammirazione e stupore.
Prima che un film, è una sfida della regista: a chi l’ha ideata, a chi la interpreta, a chi la guarda. È una sfida, ma questa ormai è un’abitudine della giovane cinematografia della regista, al ritmo usuale dei racconti mainstream ma anche di quelli sedicenti indipendenti, è l’ennesimo tentativo, riuscito, di fare un classico che sia modernissimo, è la capacità unica di attingere al suo bagaglio culturale, letterario e pittorico ma anche televisivo e cinematografico.
La trama del film della regista presenta una detective ossessionata da un serial killer con l’abitudine di lasciare sulla scena del delitto lettere scritte in stampatello quasi infantile, ma ordinatissimo, dotte e impietosamente fredde. Non è la sua unica ossessione, ne ha un’altra che l’ha corrosa, nell’animo e nel corpo. L’indagine sull’assassino è uno specchio che riflette il dolore infinito e devastante di questa poliziotta, che a sua volta è il lato oscuro di una società, di una comunità senza più riferimenti.
Attorno a lei l’amica e capa, altrettanto disperata ma più rassegnata, la figlia, una nemesi con lo sguardo feroce e il volto vuoto. E tanti, tanti protagonisti di scena che arrivano davanti a noi e con poche immagini riempiono la storia.
Si fa davvero fatica a non pensare al corpus cinematografico intero della regista disunito da questo film. Perché parla e cita e risponde a tutte le altre sue opere, perché ne è il coronamento, con un adulto adolescente che sembra il prototipo assoluto di una delle protagoniste o del padre vacuo di una delle protagoniste, che potrebbe venire da ognuno di quegli universi ma che qui urla tutto il suo talento da un profondo nord perso nel tempo e nello spazio.
C’è una linea d’ombra nella mente, nelle penne e negli occhi della regista che è il luogo infernale in cui ballano le sue protagoniste, spezzate dentro dal male, in eterno combattimento con il vuoto, con i loro corpi che cercano ciò che non possono, devono trovare. La percorrono senza paura di andare dove altri neanche immaginano.
I ritmi: ha una musica interna, una cadenza, che è unica. Dalle prime due puntate, quasi immobili, insopportabilmente impietose nell’inquadrare un mondo e una protagonista che sembrano incastrate in un orrore quotidiano e quasi squallido, alle successive quattro, che accelerano, derapano, vanno in testacoda fino all’imprevedibile finale, che sembra preso di peso da altrove, ma un altrove coerente e perfetto rispetto a quello che si è visto.
La scrittura: aulica e a tratti ironica, ma di un’ironia glaciale, quasi nordica, che ti fa sorridere mentre il tuo corpo è teso, e che tira fuori dalla poetica della regista qualcosa che finora forse avevamo intuito all’esordio e in qualche intervista. C’è il romanticismo feroce e quasi violento, che parla di amore e morte, ma non sai mai quando e quanto e come. E spesso ti parla di entrambi, o ti parla di uno schiaffeggiandoti con l’altro.
La regia, cupa e epica, ma anche pittorica come mai prima, probabilmente nell’intera storia del cinema italiano, ambiziosa e pur però obbediente a un genere specifico e che pretende i suoi schemi, quello del thriller, dell’animo e poliziesco.
Il montaggio, che sembra avere tre ritmi, diversi tra loro in modo radicale, e pure omogenei l’uno all’altro e con una rara capacità di aderire alla regia e ai suoi movimenti da apparire al contempo determinante e invisibile. Il modo in cui prende la luce e il buio, quasi teatralmente, sentendoli addosso, i suoi movimenti impercettibili del corpo e del volto, la capacità di scavarsi dentro, anche fisicamente, e portarci nella sua ossessione, nel suo sacrificio estremo, nella carneficina della sua anima e del suo mondo, il suo galleggiare nella follia, domandola e facendosene sottomettere in ogni secondo, contemporaneamente, rende la sua una delle performance attoriali più belle e complete mai viste.
Proprio con quegli occhi che piombano nell’ombra più nera mantenendo sempre almeno un barlume di luce – si intuisce il grande pregio del cinema della regista, quello di essere materia e astrazione, di saper scenderti nella carne e un attimo dopo volare nell’in(de)finito, essere nella più profonda essenza letteraria e umana di ciò che quell’autrice meravigliosa e irripetibile ci ha restituito.
E di questo dobbiamo ringraziare i demoni della regista.
La caccia al mostro in ognuno di noi. Disturbante e respingente. Il film è una discesa negli inferi con un titanico intento a far luce, o forse ombra, su una catena di delitti senza castigo. I suoi occhi sono intensi, è lei il Caronte che accompagna lo spettatore dentro un incubo chiamato. Un vomito in primo piano fa subito intuire la cifra del racconto, volutamente disturbante, sgradevole, respingente. Sarà così per tutte e cinque le ore del racconto, prendere o lasciare.
Incontriamo la protagonista nel momento più disperato: ha tentato il suicidio, vomita per rigettare non tanto i farmaci ingeriti quanto un segreto insopportabile custodito nelle viscere. È una detective di quelle che si ossessionano dietro un caso irrisolto e provano a entrare nell'anima della persona che cercano, appunto, un serial killer con la mania di lasciare lettere filosofeggianti accanto ai cadaveri. Il detective movie cede subito il passo alla contaminazione, si mischia con l'horror, il pulp, il noir, il dramma esistenziale, sociale e familiare.
Ha una figlia tossicodipendente che la detesta (unica luce tra i cocci sgangherati dell'esistenza) e che lei ama in modo disperato. I momenti tra loro due spezzano la febbre delirante della caccia all'uomo creando bolle di intimità a tratti tenera - come di fronte a un cornetto inzuppato - a tratti furiosa - come in una scena clou di rabbia repressa e autolesionismo, con un altro vomito. Alla regista piace il mare mosso, non farà mai nulla per calmare le acque.
Una promessa che pare una minaccia, fatto sta che navigare nel mare agitato del loro crime è un'esperienza interessante e quasi sensoriale: punta alla pancia, sciocca con scene repellenti, tra colonscopie e occhi cavati, e finisce per far riflettere sui grandi temi dell'esistenza. La vita, la morte, la malattia, la genitorialità, il ricambio generazionale. Ma soprattutto solleva la questione su chi sia il vero mostro, se un maniaco fuori di noi o il marcio che abita ognuno di noi. Insomma, è una serie imprevedibile, dal ritmo incalzante e vorticoso verso il finale. Un crescendo di angoscia, devastazione e cupezza, firmata da una regista che ama maniacalmente i dettagli ma non le mezze misure, tanto meno gli sguardi convenzionali. Il suo è un cinema ben girato, che preferisce indagare gli abissi e guarda agli ultimi come ai più interessanti da raccontare. La sua umanità sul lastrico, da un punto di vista emotivo, fisico e psicologico, è carica di contraddizioni da narrare.
La caccia al mostro in ognuno di noi Questo non mette al riparo da errori, imperfezioni, lungaggini, scivolamenti, specie nel trionfo dello splatter verso il finale che strizza l'occhiolino a e (ma anche a di, occhio alla penna). Resta il fatto che con la regista dimostra una maturità inedita nel governare la sua storia, sorretta dalla struttura ad orologeria del crime, e un rinnovato spessore autoriale. C'è chi dirà che è un o all'italiana, noi riportiamo la definizione della protagonista: "Un balletto ideato da chi ha il coraggio di osare narrazioni in controtendenza".
Dopo un lungo percorso, passato attraverso le sale cinematografiche, un'autrice, la prima produzione cinematografica di una regista donna, sbarca nelle case di tutti gli spettatori su una piattaforma. Con un rilascio in blocco, che permette di immergersi in questa storia curda e fosca. “Immergersi” è il termine adatto, perché è un racconto che rapisce, che opprime e che sfianca. È un vero e proprio viaggio nei meandri dell’oscurità umana. Un cammino nei più intimi recessi dell’io, in quell’esistenzialismo tanto profondo da far terrore. E per questo motivo, parlare di questo film non è facile.
Questo film è unico. Cominciamo da questo semplice assunto. Non lo diciamo in senso celebrativo, ma fattuale. Questa pellicola è unica perché in giro non c’è nulla di simile. Sicuramente non in Italia. Siamo di fronte a un’opera lontanissima dalle convenzioni. Formalmente si presenta come un noir ma l’intera narrazione viene immediatamente condotta su un piano fortemente esistenziale. A indirizzare il racconto è il netto taglio autoriale imposto dalla regista, che riversa in questo film molti degli elementi a lei cari. Dall’analisi dei rapporti genitoriali alla periferia (che qui si fa provincia) fatta di luoghi degradati e in rovina, passando per quella minuziosa esperienza delle più basse meschinità umane. Questi elementi s’innestano dunque sul noir e lo caratterizzano in maniera, appunto, unica.
Da tradizione che si rispetti relativamente al genere scelto, al centro di questo film c’è una caccia al killer. Unica anch’essa. La meccanica tipica di questo genere di racconti, infatti, assume sin da subito un’impostazione differente. Si biforca, per così dire, seguendo due direzioni principali, una “interiore” e l’altra “esteriore”. Su questi binari scorre il racconto, fino alla sua intensa conclusione, e su questi binari si posizionano anche gli snodi più interessanti su cui la regista ha innescato le sue riflessioni.
Il cammino di un personaggio. Partiamo dalla traccia “interiore” disegnata dal film. Alle calcagna del killer c’è un personaggio. Un personaggio abbondantemente ripugnante, ma capace di mettersi completamente a nudo davanti allo spettatore. La poliziotta (che durante il racconto diventa ex poliziotta a dire il vero) nel cacciare il killer finisce per dare la caccia a se stessa. La sua è una vera e propria catabasi, che la porta a dover fronteggiare i suoi peccati più oscuri e ad affrontare i conflitti della sua esistenza. Il comune denominatore in questo caso è sua figlia.
Questo film non è facile, dicevamo. E la riprova l’abbiamo nella scioccante rivelazione del quarto atto. Il plot twist sconvolgente che svela l’oscuro passato del personaggio. Non intendo, personalmente, andare a fondo sulla questione, sarebbe davvero impossibile analizzarla. Tuttavia, tutta quella sequenza che parte dalla rivelazione, prosegue con lo scontro fisico e culmina nell’autolesionismo di madre e figlia è uno dei momenti di maggiore impatto di tutta la pellicola. È il punto di non ritorno del cammino del personaggio. È l’immersione nell’acqua di un fiume mitologico, da cui la poliziotta riemerge cambiata per sempre. Decisa ad arrivare sino in fondo al suo viaggio negli Inferi. È il punto di non ritorno anche per lo spettatore, la cui esperienza con il film rimane, indelebilmente, segnata da quel passaggio.
Il rapporto tra il personaggio e il killer. La traccia “esteriore” che caratterizza questo film è data proprio dalla stessa caccia al killer. O meglio, dal rapporto che s’instaura tra il killer e il personaggio. La gestione dei ritmi narrativi è quanto mai compassata, specchio di quello spirito esistenzialista che anima il racconto. Può piacere o non piacere, ogni giudizio è legittimo in questo caso. Però, bisogna assolutamente riconoscere la genialità dell’escamotage partorito dalla regista e sceneggiatrice per caratterizzare questo film. Parliamo, ovviamente, del ricorso alle lettere.
Grazie a questo aspetto, la caccia al killer si trasforma in un rapporto epistolare. S’instaura un confronto diretto, che si concretizza nelle lettere che il killer lascia accanto alle sue vittime. Queste sono l’elemento che più di tutti esalta la scrittura profonda della regista. Sono la valvola di sfogo di quel tono esistenziale a cui il film ambisce. Ma l’aspetto ancora più suggestivo della meccanica delle lettere è la loro funzione in correlazione proprio all’omicidio. Gli scritti cristallizzano la vita proprio nel momento della morte. Mettendo su carta contorte riflessioni sugli ultimi istanti di vita delle vittime, il killer consegna le sue stesse vittime all’eternità della scrittura.
Non possiamo ignorare il legame che esiste tra la morte e la scrittura. Due dimensioni dell’assoluto. Due porte d’accesso all’eternità. Il killer consacra questo legame tramite le sue lettere e questa meccanica riflette alla perfezione quell’anelito all’assoluto che alimenta la narrazione del film. Per chi ama perdersi in discorsi sul tempo e sull’aspirazione all’eternità, come il sottoscritto, un lavoro del genere è semplicemente una goduria.
Il dramma della solitudine. “Si muore quando si viene lasciati soli” diceva un famoso magistrato, teorizzando l’impegno delle istituzioni nella lotta contro la mafia. Prendiamo in prestito questa massima per applicarla a un mondo dove, di fatto, le istituzioni quasi non esistono. Quasi non c’è una struttura civile. I protagonisti del film, un personaggio in primis, si muovono ai margini della società. Agiscono in quelle zone d’ombra della coscienza e della moralità, in un universo decadente e irrimediabilmente sconfitti. Tutti, nel film, sono soli. E non potrebbe essere altrimenti considerando il freddo universo in cui sono costretti a vivere. Si muore, sicuramente, quando si è lasciati soli. Dalle istituzioni, certo. Dagli affetti, sicuramente. Ma pure da se stessi.
Nel film la solitudine è universale. Che più universale non si può. Non solo ogni protagonista è irrimediabilmente sola, ma è anche in costante conflitto. Con gli altri, ma, come dicevamo, prima di tutto con se stessa. Ogni rapporto umano è tormentato da un conflitto irrisolto e questa massa di battaglie esteriori e interiori sono lo specchio di un mondo contraddittorio in cui il male ha ormai vinto e può dilagare. In cui il male si può fermare solo e soltanto con la morte.
La cornice estetica del film. Prendiamoci un momento per parlare dell’estetica del film. Il racconto si costruisce attorno a un triangolo ai cui vertici troviamo la crudezza, l’oscurità e l’evocazione. Tra questi poli si costruisce il racconto. L’atmosfera è costantemente fosca. A livello visivo c’è molta oscurità nel racconto e abbondano i silenzi, spezzati il più delle volte da rumori cacofonici. Non mancano le scene forti, già nella prima parte ne vediamo due esemplificative: il vomito di un personaggio e una scena medica. Ricordatevi del vomito, perché ci torneremo tra pochissimo.
Terminiamo prima la descrizione di questo triangolo che orienta l’estetica del racconto. Quasi suoni cacofonici fanno spesso il paio con ambienti scialbi, degradati e rovinati. L’immagine è quasi scarnificata, ridotta all’osso. Poi a intervalli si riempie, con alcuni passaggi evocativi che conferiscono al racconto quel tono esistenziale di cui stiamo parlando sin dall’inizio. Come potete vedere, non è facile sopportare sensazioni del genere. Calarsi per un tempo prolungato nell’oscurità, nella crudezza e nella visione. Bisogna predisporsi adeguatamente e lasciarsi trasportare per percepire addosso, e comprendere con nitidezza, il contesto disegnato dalla regista.
Torniamo, ora, al vomito. Da questo triangolo esce fuori un senso di repulsione che il film cerca orgogliosamente di provocare. C’è tanto disordine. Molta sporcizia. Tanto, tantissimo fastidio nei confronti dei personaggi. Il tutto contribuisce a creare un senso di disagio, una repulsione che viene esemplificata, appunto, dal vomito. Vomitare è, in fin dei conti, la repulsione fisica. È l’atto volto a espellere dal corpo qualcosa di nocivo. Non trovate anche voi che sia una metafora azzeccata? Tutta l’oscurità, tutto il male e tutte le ambiguità che il film racconta innescano un bisogno di espulsione nello spettatore. Un “vomito emotivo” per così dire, la cui esperienza è destinata a rimanere ben impressa.
Un’esperienza unica. Riavvolgiamo il nastro. In virtù di tutto ciò che ci siamo detti sinora, possiamo affermare che questo film è sicuramente un’esperienza unica. Ricorriamo ancora una volta a questo termine, perché è davvero il più calzante che possiamo trovare per la prima pellicola di questa regista. È facile immaginare che il giudizio del pubblico sarà ambivalente nei confronti del film. Che il sentimento sarà irrimediabilmente misto.
Questo film è un’esperienza rara. Profonda, tormentata, esistenziale. Oscura, repellente, disagevole.
GIORGIO VIALI
SCHIACCIANTE #COMPLESSO #FRAGILE #DOLENTE #LACERANTE #DELICATO #SOFFOCATO #OSSESSIONATO #INFANTILE #IMPIETOSO #FREDDO #OSCURO #DISPERATO #RASSEGANTO #FEROCE #VUOTO #DISUNITO #PROFONDO #VACUO #SPEZZATO #ETERNO #NERA #DISTURBANTE #RESPINGENTE #INSOPPORTABILE #SGRADEVOLE #REPELLENTE #ANGOSCIOSO #DEVASTANTE #CUPE #MANIACALE #INEDITA #AUTORIALE #CONTRADDITTORIA #FOSCA #INTIMA #ESISTENZIALISTA #DEGRADATI #MESCHINE #INTENSO #SCIOCCANTE #DECADENTE #TORMENTATO #SCARNIFICATA #EVOCATIVA #REPULSIVA #DISAGEVOLE #REPELLENTE
Produco MEDIAGRAMMI ovvero CONTENUTI MEDIATICI (TESTI, IMMAGINI, VIDEO)
Produco anche CONTENITORI per questi ELEMENTI MEDIATICI.
IMMAGINO STORIE.
IMMAGINO PERSONAGGI e TRAMA.
Poi PRODUCO dei CONTENITORI dove esporre i MEDIAGRAMMI.
PRODUCO STRUTTURE per forzare INTERAZIONI.
O MICRO INTERAZIONI
INTERAZIONI TESTUALI, FOTOGRAFICHE, VISIVE.